L'enigma di Piero
in ricordo del Prof. Giuseppe Nomi
08/06/08
Sono Roberto,
le scrivo queste righe per ringraziarla per il suo lavoro “L’enigma di Piero”.
Sono un milanese trasferitosi a Sansepolcro da alcuni anni. Non sono uno studioso di arte, semplicemente un curioso. Da quando, circa otto anni fa, ho conosciuto il Prof. Giuseppe Nomi la curiosità è diventata anche passione.
Non so se lei ha conosciuto il Prof. Nomi (purtroppo recentemente scomparso) fondatore e poi preside dell’Istituto d’arte di Anghiari, grande conoscitore di Piero della Francesca e scopritore di un affresco di Piero nella ex chiesa di Santa Chiara a Sansepolcro. Una persona veramente squisita.
Quando appena pubblicato il suo libro, mi è stato regalato da amici, sono sincero, l’ho accolto con un pizzico di scetticismo, poi appena aperto e iniziato la lettura, con gioia mi sono ricreduto.
Mi è piaciuto anche il modo con cui lei ha trattato questo argomento, come una specie di romanzo per i “non addetti ai lavori” e contemporaneamente con tutte le informazioni e riferimenti utili per degli approfondimenti.
Contemporaneamente iniziavano anche le disquisizioni con Beppe Nomi, anche lui scettico all’inizio, poi sempre più curioso.
Con piacere le segnalo che anche lui ha condiviso la sua tesi sull’interpretazione del quadro, ma in particolare era contento per il metodo scrupoloso e scientifico con cui è trattato l’argomento, in un mondo dove regna tanta ignoranza e presunzione.
Queste poche righe, sono anche un ringraziamento a, e da parte di Giuseppe Nomi
Grazie
Arrivederci
Roberto
Caro Roberto,
il fatto che abbia inviato questa lettera in modo non direttamente leggibile dai visitatori del sito mi induce anzitutto a domandarmi, anzi a domandarle, se desidera o no che venga pubblicata interamente in chiaro nel Libro degli Ospiti.
La ringrazio davvero per le sue parole cosi' belle sul mio Enigma di Piero, e soprattutto per il ricordo toccante che trasmettono di una personalità come quella di Giuseppe Nomi.
Sapere che anche lui ha letto o cominciato a leggere il mio libro mi lusinga e mi commuove. Cosi' come il fatto di avere vinto le esitazioni di due lettori, come voi, esigenti e scettici.
Faccio parte anch'io di questa categoria, che dunque conosco bene. Convincere, in parte almeno, dei lettori miei affini era il piu' ambizioso degli obiettivi - un inconfessato obiettivo su cui ero scettica!
Un caro saluto,
SR
Cara Silvia Ronchey
La ringrazio per la sua risposta, e vorrei risponderle al quesito sulla pubblicazione sul libro degli ospiti.
Il motivo principale è stato perché le facevo riferimento al prof. Giuseppe Nomi, persona di tanta cultura quanta riservatezza, oltre che grandissima saggezza ed umiltà.
Le cito solo un esempio: nelle nostre discussioni, esprimeva una tesi (10 secondi) portava la sua dimostrazione (mediamente un ora) e poi chiudeva con l’espressione “sbaglio?”
Non si poneva mai come il depositario di verità assolute.
Ecco perché ci è piaciuto il suo libro: una tesi con il massimo delle dimostrazioni trovate, senza forzature pretestuose.
Comunque se volesse pubblicare questi scritti interi o in parte, nel libro degli ospiti, si senta in piena libertà.
Un particolare, secondo me non indifferente, che mi ha aiutato ad apprezzare il suo libro, è la forma espositiva. Sia una forma semplice e descrittiva, quasi fosse un romanzo, contemporaneamente a tutte le notizie tecniche del caso. Pertanto un libro utile ai “profani” come me, che hanno modo di accrescere la loro cultura, sia in modo semplice o più approfondito, come agli “addetti ai lavori”.
Questo sicuramente le ha attirato qualche critica, ho letto qualcosa del tipo “è un libro nato sull’onda del codice di Brown”; (forse chi ha scritto, non ha letto).
A proposito di modi diversi di lavorare, ho letto anche il libro di Bernd Roeck “Piero della Francesca e l’assassino”.
Non posso dire che abbia usato la stessa sua professionalità, anzi tutt’altro. Mi è sembrato molto approssimativo, intento a “costruire” più che “trovare” prove.
(Purtroppo non ho più il prof. Nomi con cui discutere di questo).
Riporto come esempio due paragrafi successivi presenti a pag. 48,49 dove questa contraddizione è evidente: prima si presenta una “certezza” provata con prove “non provanti” (le tonalità citate come prova, Piero le potrebbe avere apprese in molti modi); poi si chiude il discorso “riparando” in una generica ipotesi per, come si dice, “salvare capra e cavoli”.
Un’ulteriore prova del fatto che Piero sia stato testimone oculare della processione dei greci, è fornita dal colore del cappello di Pilato, per il quale sono impiegate le stesse tonalità documentate da appunti scritti di Pisanello. Solo le raffigurazioni dipendenti dalla medaglia – come il Teseo cesenate o il dipinto di Perugia – attribuiscono allo skiadion dei colori immaginari. Una medaglia di bronzo, del resto, mostra solo forme, non colori. Su quella di Pisanello, inoltre, non v’era traccia né dell’ “antico” seggio di Pilato, né dei suoi stivali purpurei, simbolo di potere appartenente al costume del “porfirogenito” imperatore d’oriente.
In qualsiasi modo Piero sia venuto a conoscenza dell’aspetto del Paleologo, si trattò di una fonte significativa per raffigurare con archeologica precisione le vesti di dignitari e sovrani dell’antico oriente.
Le ho riportato questo esempio, non solo come riconoscimento del suo lavoro, ma perché sul suo sito ho visto che è previsto un incontro a Venezia il prossimo 23 giugno dove saranno messe le due tesi a confronto.
Io non so, cosa veramente Piero ci abbia voluto trasmettere, non so quale sia la tesi più verosimile, sulle dimostrazioni a queste tesi, secondo me, non c’è storia.
Un caro saluto
Roberto
Caro Roberto,
lei ha colto in pieno l'intento del mio libro: la forma mentis, il metodo di ricerca e di conseguenza quello espositivo, sono in effetti proprio quelli che lei descrive. In questo senso, mi riconosco nella frase d'esordio del testo di Elémire Zolla che ho trascritto e pubblicato sulla Stampa di domenica scorsa - pagina che può trovare fra l'altro pubblicata nella homepage di questo sito - e che suona così: "So alcune cose, altre le so meno, altre non le so, ma se dovessi dire che so qualcosa perché ci credo direi una menzogna".
Quanto al libro di Roeck, le sue tesi non mi convincono e le sono molto grata per avere esemplificato il passo che l'ha colpita negativamente. Anzi, se lei volesse, di qui al 23 giugno, farmi avere altri esempi delle sue riserve, ne sarei ben lieta: le espliciterei nel corso del duello veneziano. Penso infatti che le mie critiche a Roeck possano essere, con tutta la buona volontà, condizionate da una visione di fondo che ormai ha in me radici decennali, e dunque meno oggettive di quelle provenienti da un lettore, come lei, attento e competente, ma nello stesso tempo equanime e distaccato nel giudizio.
Anzi, colgo l'occasione per estendere questo invito anche ai possibili altri visitatori del sito che leggeranno la sua lettera e questa mia risposta.
Un cordialissimo saluto,
SR
L'enigma di Piero
11/03/08
Cara Silvia, ho letto il tuo bellissimo “L’enigma di Piero”, questa estate sul Garda. Ero a Limone, dove è sempre fresco e mi è tornato in mente tutto: te e Scaraffia quella sera in un teatrino di Trastevere, le risate, anche un po’ di nervosismo, ma tanta simpatia. E poi il mio editore, Francesco Maria Gallo, le tue battute sulla strage degli alberi dell’Amazzonia che si cela dietro ogni libro, e io che rispondevo ma cavolo, pubblico per la prima volta a cinquanta anni e devo subito pentirmi d’averlo fatto… Forse dovevo ascoltarti e tornare nel silenzio. Ho pubblicato un libro di racconti nel 2003 e il mio editore il mese dopo ha pubblicato Vanna Marchi, e poi – sempre di fila - è fallito. Poi ho pubblicato con la Bohumil Edizioni di Bolo
gna un libricino di poesie (100 copie digitali, forse qualche ramo dell’Amazzonia, non di più). Ecco, non voglio disturbarti, solo brevi notizie ma con tanto affetto e stima per quello che scrivi. Un caro saluto.
Franco
Caro Franco,
che piacere sentirti. Sai, alberi amazzonici a parte, resto convinta che si pubblichino troppi libri, e che in ogni caso sia bene, se proprio uno non vuole tenersi i propri scritti nel cassetto, essere breve (il mio Enigma di Piero, ad esempio, sono contenta ti sia piaciuto ma è troppo lungo: il prossimo, sulla caduta di Costantinopoli, cercherà di non superare le 150 max 200 pagine). E però scrivere, caro Franco, scrivere bisogna, sempre, per carità. Tieni duro, quindi. E un abbraccio!
SR
A proposito di Piero
16/02/08
Buongiorno
Sono un profano appassionato di storia e arte. Non sono quindi uno specialista né uno studioso perciò provo a esporle la mia richiesta senza farle perdere troppo tempo.
Ho letto da poco il suo bel libro sulla “flagellazione” di Piero e ne sono rimasto entusiasta. E’ difficile leggere oggi un libro di storia così denso, preciso, documentato e coinvolgente. Ne sono uscito però anche pieno di dubbi e di domande (ma non può essere altrimenti, se il libro vale davvero qualcosa).. Nel frattempo ho letto il nuovo saggio di Bernard Roeck sullo stesso argomento, che ripropone la tesi del legame con l’assassinio di Oddantonio.
Anche se non sono un esperto, credo che il suo libro (a differenza, forse, di quello di Roeck) sia uno di quelli che “lasciano un segno” e immagino che avrà suscitato discussioni e dibattiti. Ci saranno stati nuovi sviluppi, conferme o dubbi ma purtroppo di tutto questo è difficile trovare traccia sui normali mezzi di informazione. Le chiedo perciò se è possibile avere qualche indicazione sui luoghi ove questo dibattito si è sviluppato, in modo da poter seguire ancora un poco quella storia affascinante che Lei ha saputo indagare così bene.
Spero davvero che Lei abbia qualche minuto per una risposta. In ogni caso la rigrazio per l’attenzione e, soprattutto, per quello che fa per la nostra cultura.
Con amicizia e affetto.
Walter
Caro Walter,
anzitutto grazie delle sue parole così lusinghiere.
Tutto quello che è stato scritto sulla mia interpretazione della Flagellazione è pubblicato nella pagina del sito dedicata all'Enigma di Piero (nella sezione "Recensioni", ma troverà materiali anche nelle interviste e nei programmi radiofonici e televisivi, che pure sono disponibili).
In effetti però, se debbo dirle, è mancato finora qualcosa di molto prezioso, almeno sulla stampa ufficiale: le obiezioni e le confutazioni.
Anche nei due principali pubblici dibattiti con i massimi esperti di Piero tra gli storici dell'arte italiani, Carlo Bertelli e Antonio Paolucci (organizzatori, fra l'altro, della recente mostra su Piero, al cui catalogo ho peraltro anch'io contribuito), che hanno avuto luogo pochi mesi fa, l'uno al Palazzo Ducale di Urbino, proprio davanti alla tavola di Piero, e l'altro a Bologna, nel contesto di Artelibro (questo secondo dibattito era denominato "certame", dunque avrebbe dovuto essere un vero e proprio "duello", ma è stato quasi un minuetto, lusinghiero per me, e molto interessante dato l'interlocutore; trova le indicazioni esatte su entrambi i dibattiti, così come sugli altri eventi simili, nella sezione "Agenda" del sito), non sono stati tanto controversiali quanto avrei sperato.
Né sono ancora arrivate le recensioni critiche (che prima o poi certo appariranno) sulle riviste scientifiche italiane e internazionali. La sola apparsa, sul Journal für Kunstgeschichte, in italiano fra l'altro, è anch'essa stata inserita nel sito. Sullo stesso numero della stessa rivista è apparsa anche una recensione (molto dura) del libro di Roeck.
Ma proprio da quando è uscito (ora anche in italiano) il libro di Roeck, sembra che qualcosa di realmente simile a una discussione dura, tesa e senza complimenti sia nell'aria.
Come è annunciato nell'articolo di Pierluigi Panza apparso recentemente sul Corriere della Sera (e anch'esso inesorabilmente pubblicato nel sito), il 23 giugno prossimo all'Istituto Tedesco di Studi Veneziani, a Palazzo Barbarigo della Terrazza, sul Canal Grande, si terrà un vero e proprio duello, in cui i due avversari - Roeck ed io - saranno affiancati ciascuno da due "scudieri" (così li hanno denominati i seri e severi organizzatori germanici), scelti tra i massimi storici dell'arte italiani e stranieri esperti di Piero della Francesca o comunque degli argomenti portati dai due libri.
Sarebbe magnifico se anche lei fosse tra il pubblico - o, chissà, tra i duellanti e dibattenti.
SR
Bessarione
21/01/08
Cara Silvia Ronchey,
dopo aver letto il suo Enigma di Piero, a parte averla laicamente benedetta per aver scritto un libro così distante dal parrucconismo di certi storici dell'arte (ho lavorato nel campo per una ventina d'anni, dalla parte della redazione, pertanto di parrucconi ho una certa esperienza), e averla benevolmente invidiata per quello che ha prodotto, sono uscita dall'esperienza con una specie di ossessione per la frase di Capranica (Hai mai visto Bessarione senza un libro in mano?).
Quanto sto per dirle susciterà probabilmente il suo orrore: ho ideato una linea di merchandising letterario, che declina un marchio ispirato a
Bessarione e la frase di Capranica su una serie di oggetti. La cosa è venuta veramente bene e a questo punto mi chiedo e le chiedo: le seccherebbe vedere in giro oggetti siffatti? Gente che va in giro con una t-shirt ispirata al bravo cardinale o cose del genere? Crede che ci siano questioni di proprietà intellettuale?
Grazie per la sua opinione,
Anna
Cara Anna,
idea fantastica! Conto che gli altri Ospiti di questo Libro abbiano commenti e consigli.
Dorate spighe
16/01/08
Gemisto
31/12/07
Gentilissima signora,
prima che finisca l'anno -un anno felicemente segnato da Piero e dall'Enigma- desidero ancora una volta ringraziarla del gran bel dono e, con l'occasione degli auguri, affidarle la sintesi delle riflessioni che l'uno e l'altro mi hanno suggerito, autorzzandola a cestinarle tout court se, come temo, le riterrà assurde.
Sulla scia di Dario e di alcune suggestioni malatestiane mi sono fatto l'idea che il dipinto sia stato commissionato per celebrare Gemisto e il suo Sogno, forse quando fu traslato a Rimini.
Un dio pagano sovrasta sfolgorante il Cristo alla colnna e i conflitti polito religiosi del tempo. Dall'altra parte, dentro un cielo di primavera, svetta smisurato un alloro.
Apollo Elios, luce e governo del cosmo, cacciato dalla sua terra ha messo radci da noi.
Il lume di scena, come il carro del sole, migra da oriente ad occidente. Il greco, le spalle al passato, sta slla soglia di un mondo nuovo.
La flagellazione è il pretesto, l'imperatore ed il sultano delineano il contesto storico, ma il tema è "la città ideale" a cui, dei tre personaggi al proscenio, solo appartiene il giovane scalzo (il greco non osa entrarvi e il committente, come i committenti, sta nel quadro ma vi è estraneo): è'l'uomo nuovo che l'alloro, sacro ad Apollo, incorona e quasi genera.
E il grande albero che tutto domina e da cui tutto sembra promanare è forse -se ricordiamo la lettera di Bessarione ai figli- Gemisto stesso, gloria sempiterna.
La ringrazio dell'attenzione che vorrà riservare a questa follia e la saluto augurandole di cuore un felicissimo anno nuovo
piero



Indagini sulla «Flagellazione»
02/10/07
Gentile Dottoressa Silvia Ronchey,
rispondo alla sua mail riguardante un particolare della figura del
sultano turco nel dipinto "La Flagellazione di Cristo".
A prima vista il soggetto appare scalzo e personalmente ritengo che
lo sia. Ho notato che la figura del sultano riceve luce di fronte ed
il suo versante posteriore è in ombra, ed è quindi naturale che i
suoi piedi appaiano più scuri rispetto ai piedi scalzi di altri
personaggi della scena che ricevono invece luce diretta e più
intensa. Tuttavia il dipinto ha perso saturazione cromatica nel
corso dei secoli, si presenta sicuramente più "slavato" di quanto era
in origine ed un particolare che oggi è più o meno "color pelle", in
origine poteva avere un colore più saturo, diverso da quello che
vediamo ora, e quindi compatibile con l'ipotesi di un qualche tipo
di calzatura aderente.
Un esame scientifico su questo ed altri argomenti affini mi fa subito
pensare al Dipartimento di Energetica dell'Università di Roma La
Sapienza che ha un ottimo laboratorio di analisi non distruttive ed
archeometria la cui attività è descritta nell'articolo che allego a
questa mail e che richiede qualche secondo per essere visualizzato.
Non molto tempo fa contattai il Prof. Mario Piacentini, proprio in
merito ad un esame sul dipinto in oggetto, che mi rispose dando prova
non solo di grande passione e disponibilità, ma anche di preparazione
e competenza specifica in esami scientifici che riguardano le opere
d´arte.
Le invio anche una fotografia scattata da un mio collega al dipinto
di Piero della Francesca, in cui si possono vedere bene i piedi del
personaggio del sultano turco.
Con stima sincera,
Claudio
Carissimo Claudio,
perdoni il ritardo di questa risposta, ma la pausa estiva ha avuto
tra i suoi effetti anche un rallentamento degli scambi di
corrispondenza del sito, che ora tuttavia stanno tornando a regime.
La ringrazio moltissimo sia delle sue acute osservazioni, sia del
suggerimento di rivolgerci al Laboratorio del Dipartimento di
Energetica della Sapienza, con cui prenderemo quanto prima contatto,
nella speranza di poter presto pubblicare in questa sede nuove
informazioni, sia del materiale che ci offre, e che mettiamo a
disposizione degli altri visitatori del sito interessati
all'appassionante argomento.
Naturalmente, contiamo anche in futuro sul suo apporto a una ricerca,
che, per definizione, non ha fine: il protocollo d'indagine, per un
caso come questo, resta sempre aperto, no?
SR
Gentile Dott.ssa Silvia Ronchey,
l'indagine è ancora aperta e si è arricchita di nuovi elementi che un collega della sezione UACV (Unità di Analisi del Crimine Violento)ha evidenziato grazie alla sua esperienza nella comparazione di volti umani. Lo scopo è dare una identità certa ai personaggi dipinti da Piero Della Francesca, non solo nella "Flagellazione di Cristo" ma anche in altre opere a lui attribuite.
Non posso dire altro al momento perchè io mi sono occupato solo dell'argomento illuminazione e di come le ombre all'interno della loggia convergano in un unico punto.
Il suo autorevole interessamneto al nostro operato ci incoraggia ed inorgoglisce molto. La terrò informata sulle novità.
Con stima sincera,
Claudio
Carissimo Claudio,
di nuovo grazie delle preziose informazioni sul lavoro che state svolgendo: ci tenga al corrente!
SR
I piedi del sultano e l'ubriaco di Gombrich
31/08/07
Gentilissima signora,
è vero che, come l'ubriaco di Gombrich, anche noi cerchiamo le "chiavi" là dove c'è la luce dei nostri preconcetti; e questa, nel mio caso, non avrebbe potuto che illuminare piedi calzati, dal momento che non riesco neppure a concepire il Turco con le insegne degli dei e degli eroi.
D'altra parte, mi pare, solo se fossero nudi -e, dunque, palesemente trasgressivi di un codice iconografico consolidato- dovremmo ritenre che a quei piedi Piero abbia affidato il compito di alludere ad altro: verosimilmente proprio alle mire del sultano di "scalzare" l'imperatore bizantino.
Se così non fosse, però, verrebbe forse meno l'anello più solido -perchè inequivoco- della catena dei piedi, non bastando quelli del bel giovane misterioso a reggere da soli il "gioco dei calzari di porpora", posto che la loro nudità risulterebbe compatibile tanto -se non più- con l'assolutezza di figure ideali, quanto con la contingenza di una successione al trono.
Piero
Carissimo Piero,
la ringrazio davvero delle sue ipotesi e riflessioni, che come avrà potuto constatare hanno sollecitato l'interesse e l'intervento di altri visitatori del sito: siamo in attesa di una definitiva diagnosi sui pigmenti, che come ci suggerisce nella sua mail Claudio De Simoni, del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona, potrebbero venirci dal Laboratorio di analisi non distruttive ed archeometria del Dipartimento di Energetica dell'Università di Roma La Sapienza, e in particolare dal Prof. Mario Piacentini.
Anch'io ormai ho occhi presbiti, e in ogni caso è ciò che l'occhio non può vedere, quanto meno se privo dell'assenso dell'intelletto, che più interessa il cultore di ogni ricerca - io credo.
SR
Gentilissima signora,
la ringrazio della cortesia con la quale ha risposto alla mia pecedente lettera, ma ancor più voglio ringraziarla -cosa che, preso com'ero dai piedi del turco, imperdonabilmente non ho fatto prima- del grande dono dell'Enigma.
Come "personali strumenti d'indagine" ho solo occhi ormai presbiti, e da sempre un po' daltonci, dei quali, come è ovvio, non posso fidarmi.
Le auguro una buona vacanza
Piero
L'enigma di Piero, traduzione in altre lingue
19/08/07
Dear professore Ronchey,
With ‘red ears’ i am reading your fascinating book/thriller on Piero’s Enigma. For me it is a little difficult, because of my deficient Italian. But perhaps the book will be translated in English. For me a special interest in the subject of this book is the project on which a colleague Zweder von Martels, and I am working, already five years: a study on Enea Silvio Piccolomini, and a translation of selected parts of his works. In the middle of this is the crusade-plan of Pius and, as you writes, Bessarion. The translation into Dutch of these writings is my job.
On my internet-site you can find something. I have made a link to your url with the music of Dufay with text scrolling of this beautiful motet.
( http://home.planet.nl/~golds067/navigat.htm )
I hope you will continue your investigation.
Best wishes and regards,
michel
Caro Michel,
le rispondo in italiano, visto che conosce questa lingua abbastanza da essersi avventurato (ne sono più che lusingata) nel mio Enigma di Piero, e anche perché tutti i visitatori del sito possano leggere la risposta alla sua gradita mail.
Sono certamente molto interessata ai suoi studi su Enea Silvio e sul tentativo di crociata in Moerea, così come in generale all'insieme del progetto che ha in corso con Zweder von Martels. E sono felicissima del link con il suo sito, che in effetti potrebbe incrociarsi e anche approfondirsi (ad esempio, cross-links specifici potrebbero collegare parti del mio Regesto Maior di note a parti del progetto olandese).
Ma mi rendo conto che per una collaborazione piu' proficua la lingua italiana non è l'ideale. E ne approfitto per segnalare a lei, e a quanti dovessero leggere questa risposta, che mentre sono già in corso le traduzioni in francese (per la casa editrice Les Belles Lettres) e in greco moderno (per la casa editrice MIET) dell'Enigma di Piero, il libro non ha ancora trovato - francamente non capisco perché, penso davvero sia un caso - un editore in lingua inglese. Rivolgo quindi ai lettori, oltre che a lei, un piccolo appello: conoscete qualcuno che abbia voglia di tradurlo in lingua inglese? vi viene in mente qualche editore che possa avere voglia di pubblicarlo, in Inghilterra o in America?
SR
La flagellazione di Cristo
27/07/07
Gentile Dottoressa Silvia Ronchey,
rispondo alla sua mail riguardante un particolare della figura del sultano turco nel dipinto "La Flagellazione di Cristo".
A prima vista il soggetto appare scalzo e personalmente ritengo che lo sia. Ho notato che la figura del sultano riceve luce di fronte ed il suo versante posteriore è in ombra, ed è quindi naturale che i suoi piedi appaiano più scuri rispetto ai piedi scalzi di altri personaggi della scena che ricevono invece luce diretta e più intensa. Tuttavia il dipinto ha perso saturazione cromatica nel corso dei secoli, si presenta sicuramente più “slavato” di quanto era in origine ed un particolare che oggi è più o meno "color pelle", in origine poteva avere un colore più saturo, diverso da quello che vediamo ora, e quindi compatibile con l'ipotesi di un qualche tipo di calzatura aderente.
Un esame scientifico su questo ed altri argomenti affini mi fa subito pensare al Dipartimento di Energetica dell'Università di Roma La Sapienza che ha un ottimo laboratorio di analisi non distruttive ed archeometria la cui attività è descritta nell'articolo che allego a questa mail e che richiede qualche secondo per essere visualizzato.
Non molto tempo fa contattai il Prof. Mario Piacentini, proprio in merito ad un esame sul dipinto in oggetto, che mi rispose dando prova non solo di grande passione e disponibilità, ma anche di preparazione e competenza specifica in esami scientifici che riguardano le opere d’arte.
Le invio anche una fotografia scattata da un mio collega al dipinto di Piero della Francesca, in cui si possono vedere bene i piedi del personaggio del sultano turco.
Con stima sincera,
Claudio De Simoni
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona.

Carissimo Claudio,
perdoni il ritardo di questa risposta, ma la pausa estiva ha avuto tra i suoi effetti anche un rallentamento degli scambi di corrispondenza del sito, che ora tuttavia stanno tornando a regime.
La ringrazio moltissimo sia delle sue acute osservazioni, sia del suggerimento di rivolgerci al Laboratorio del Dipartimento di Energetica della Sapienza, con cui prenderemo quanto prima contatto, nella speranza di poter presto pubblicare in questa sede nuove informazioni, sia del materiale che ci offre, e che mettiamo a disposizione degli altri visitatori del sito interessati all'appassionante argomento.
Naturalmente, contiamo anche in futuro sul suo apporto a una ricerca, che, per definizione, non ha fine: il protocollo d'indagine, per un caso come questo, resta sempre aperto, no?
SR
Urbino, 15 giugno 2007
14/07/07
Gentile Dottoressa Silvia Ronchey,
sono Claudio, fotografo della Polizia Scientifica, che ha avuto il grande piacere di assistere il 15 giugno ad Urbino, alla tavola rotonda sul dipinto "La Flagellazione di Cristo" di Piero della Francesca.
La relazione da me redatta sulle luci ed ombre del dipinto si inserisce in una più ampia analisi che l'Ufficio in cui lavoro sta sviluppando, coordinata dal Dirigente Dot. Silio Bozzi. Con la nostra ricerca miriamo ad evidenziare elementi nuovi riguardanti il dipinto utilizzando tecniche proprie della Polizia Scientifica.
Complimenti per la ricchezza delle sue ricerche e per il modo chiaro e coinvolgente di esporle. Grazie di tutto.
Distinti saluti,
Claudio
Carissimo Claudio,
sono veramente felice del suo messaggio. Anche perche' l'indagine che lei e i suoi colleghi state svolgendo sul dipinto potrebbe aiutarci a risolvere alcuni altri problemi.
Uno e' quello che ha appena sollevato un altro lettore, di nome (omen!) Piero, la cui mail può trovare inserita in questo stesso Libro degli Ospiti: il sultano turco è davvero scalzo, o potrebbe indossare dei calzari aderenti? Solo tecniche sofisticate come quelle di cui ritengo disponga la Polizia Scientifica potrebbero arrivare a una disamina della stesura pittorica in grado di appurare se esista realmente una discrasia tra questo e gli altri soggetti. Ma è solo un esempio del grande interesse che nutro per il suo e vostro lavoro, del quale, la prego, mi tenga e ci tenga informati!
SR
Il sultano scalzo
14/07/07
Gentlissima signora,
a pag. 241 del suo bel libro su Piero,a proposito dl sultano turco,lei scrive: "Ma è scalzo".
Ma è proprio scalzo?
Il colore -più carico- e la forma -meno filante, specie alla caviglia- fanno sospettare il contrario; e visto il ruolo che qui giocano i piedi, qualche parola in più non guasterebbe.
La ringrazio per l'attenzione.
Piero
Caro Piero,
la sua osservazione è davvero interessante.
Le dirò che non avevo mai pensato (come del resto, a quanto mi risulta, neppure gli altri storici interessati alla Flagellazione) che il sultano turco possa non essere scalzo.
Occorrerà approfondire, e si potrà farlo, magari, con l'aiuto di un altro visitatore del sito, Claudio De Simoni, le cui coordinate e le cui notizie potrà trovare in questo stesso Libro degli Ospiti.
Sempre che lei non abbia personalmente altri strumenti d'indagine.
Per ora un saluto e un sincero ringraziamento per il suo contributo alla ricerca, che com'è noto, se è ricerca vera, non finisce mai!
SR
Urbino, 15 giugno 2007
14/07/07
cara Silvia,
grazie ancora per l'invito alla presentazione urbinate: è stata un'esperienza memorabile; ha forse avuto tempo per guardare il 'corto' che le ho dato? in caso positivo, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa; grazie e a presto.
Luca
Caro Luca,
confesso che da quando ci siamo incontrati a Urbino non ho mai smesso di pellegrinare e non ho ancora avuto modo di fermarmi davanti a un televisore e guardare il suo corto. Ma ne sono curiosissima e lo faro' quanto prima.
Per ora un saluto,
SR
Piero Regiomontano
14/07/07
Carissima Silvia,
dopo il mio ultimo messaggio del 5 febbraio, nel quale ti chiedevo notizie di una connessione Piero-Bessarione-Regiomontano, sono successe molte cose nel mio lavoro su Piero, tra cui la fine (finalmente) dell'elaborazione critica dei disegni del trattato d'Abaco, e la pubblicazione di un breve saggio su Piero e gli astri, apparso sul catalogo della mostra Piero della Francesca e le corti Italiane. Io ipotizzo un incontro Piero Regiomontano e propongo una datazione più tarda per il Sogno di Costantino (1464).
Come vanno i tuoi studi? Sei ancora in Italia o in qualche parte del mondo?
Ciao,
Vladimiro
Carissimo Vladimiro,
sai che, pur essendoci anche un mio saggio, non ho ancora ricevuto il catalogo della mostra di Arezzo?
Sono molto curiosa di leggere il tuo scritto su Piero e gli astri. Un incontro Piero-Regiomontano, per quanto posso giudicarne io in base ai dati che ho sul suo soggiorno con Bessarione, e' logisticamente probabile. Se poi ne hai trovato tracce iconografiche inconfutabili, be', la cosa diventa entusiasmante, anche perche' sarebbe l'unica dimostrazione positiva e certa (a parte il perduto ritratto delle stanze vaticane) che Bessarione e Piero si conoscessero personalmente. Riesci a mandarmi un estratto del tuo scritto, in attesa che Skira' mi mandi il volume?
Per ora un saluto, e complimenti.
SR
Corridoio bizantino
22/06/07
Gentile Prof.ssa Ronchey,
dopo averla ascoltata con tanto interesse a Palazzo Ducale sull’”Enigma di Piero” ho potuto cogliere la sua disponibilità ad ascoltare anche i non esperti, ed io sono tra quelli.
Vivo ad Urbino e possiedo una casa in un piccolo paese, dista 15 chilometri da Urbino, chiamato Monteguiduccio frazione del Comune di Montefelcino.
La mia casa e altre case del piccolo centro storico sono attraversate da sotterranei chiamate “grotte” aventi un’altezza di circa 2 m ed una larghezza circa 1,30 m che continuano fuori del paese per 3-4 chilometri fino a raggiungere una chiesa isolata detta “Chiesa di Santo Stefano di CasaRotonda”.
Dell’esistenza delle grotte fuori il paese sono rimaste le testimonianze delle persone più anziane in quanto nel tempo il territorio con la costruzione della strada asfaltata, varie frane ecc. ha subito notevoli modificazioni.
Qualche anno fa visitò le grotte di casa mia il Prof. Giancarlo Gori (Ispettore Onorario per i Beni Culturali della vicina Fossombrone) ipotizzò che potessero far parte del “corridoio bizantino” e mi disse che i sotterranei di una casa del centro di Fano (distante 35 Km dal mio paese) da lui visitata erano molto simili.
Ora io chiedo a lei se dalle foto, che le invio in allegato è in grado di avvallare l’ipotesi del Prof. Gori e a quali studiosi eventualmente contattare per contribuire con questa testimonianza ai lori studi e ricerche.
Nel ringraziarla la saluto cordialmente e se dovesse tornare ad Urbino la inviterei a visitare il mio paesino.
Ester






Cara Ester,
la ringrazio per la documentazione davvero preziosa che mi ha inviato.
Provvederò a interpellare in materia i miei colleghi archeologi. Nel frattempo, mi permetto di inserire la sua mail nel Libro degli Ospiti del mio sito (www.silviaronchey.it), perché una risposta o un supplemento di documentazione possa giungere anche da altri lettori e visitatori.
Le farò sapere presto (e sì, verrò certamente a visitare Monteguiduccio e le sue grotte!).
Un cordiale saluto,
SR
Complimenti
16/05/07
Egr.a prof.ssa Ronchey,
sto leggendo il libro 'L'enigma di Piero' e vorrei ringraziarLa, semplicemente.
(Infatti non trovo le parole per trasmettere l'entusiasmo che provo nel leggerlo e nel diffonderlo presso amici in grado di apprezzarlo).
Mi ha aperto gli occhi e mi pare di capire, adesso, molto di più le complesse vicende storiche e la cultura moderna, mediterranea e veneziana. Ma è anche la struttura che Lei ha scelto di dare all'opera che mi affascina e che le conferisce una particolare 'spazialità' (mi passi, La prego, questo attributo architettonico)
Grazie!!!
Barbara
Carissima Barbara,
la ringrazio davvero delle lodi e dell'entusiasmo, tanto più gradito da parte di una veneziana!
SR
Niccolò III
10/03/07
Gentile Professoressa Ronchey,
mi permetto di disturbarla per associarmi agli apprezzamenti entusiastici del suo recente libro sulla Flagellazione. Per quanto possa valere la mia opinione,(sono dilettantisticamente appassionato di pittura rinascimentale, in particolare di Piero della Francesca), trovo convincente l'identificazione del gentiluomo in broccato con Niccolò III.
Mi rimarrebbe la curiosità di chiederle che evoluzione abbia avuto una precedente ipotesi sull'identificazione del gentiluomo in broccato, che lei in passato sarebbe stata incline a riconoscere come Ludovico Gonzaga, (secondo quanto riferì Marco Carminati in un articolo sul Domenicale del Sole 24 ore del 7-4-2002), sulla base di riscontri concernenti un rimando all'araldica gonzaghesca del motivo ornamentale della pellanda e ad un busto bronzeo conservato a Berlino.
Non mi pare di aver trovato, nel libro o nel regesto maior online, tracce di questa precedente ipotesi.
cordiali saluti
Dino
Caro Dino,
grazie, anzitutto, dei suoi apprezzamenti e della sua mail.
Le ragioni che mi hanno indotto a scartare l'ipotesi, già formulata da Marilyn Lavin e da me ripresa nell'articolo apparso sulla Byzantinische Zeitschrift dell'anno 2000 ed esposto nel resoconto di Carminati, sono varie e difficilmente sintetizzabili del tutto in poche righe.
Posso dirle che da un lato, avendo ottenuto dopo lunga attesa dal Bode-Museum di Berlino le foto del busto bronzeo secondo altre angolazioni, la somiglianza non appariva più così netta, e peraltro alcuni dettagli la contraddicevano. D'altro lato, come mi ha fatto notare già all'uscita del contributo scientifico sulla BZ Salvatore Settis, se il "piano della trattativa" è da situarsi cronologicamente nel 1438 e non nel 145859, è impossibile, per le leggi stesse della pittura, che due personaggi ritratti in due momenti storici diversi dialoghino fra loro sullo stesso piano: dunque il Bessarione trentenne del concilio di Ferrara del 1438 non potrebbe in nessun caso trovarsi accostato, allo stesso livello prospettico, al padrone di casa della conferenza di Mantova del 1459.
Di qui sono partite le mie ricerche: se il concilio raffigurato è quello di Ferrara, e ce lo indica, oltre all'età di Bessarione, anche e soprattutto la presenza di Giovanni VIII sul trono, che è una vera e propria forma di datazione degli eventi del quadro da parte del suo autore, come avrà letto nel mio libro, allora occorreva trovare un personaggio estremamente eminente e autorevole, come indicano sia la sontuosità della veste, sia il drappo rosso, e certamente riconoscibile agli spettatori del quadro, che avesse l'età e il ruolo del gentiluomo in broccato, ma vent'anni prima.
Niccolò III mi è venuto subito alla mente, e lo avevo quasi scartato perché fin troppo ovvio, finché non ho trovato notizia della quasi certa esistenza e circolazione di una sua medaglia, eseguita da Pisanello e oggi purtroppo perduta. Di qui, sulle tracce degli schizzi preparatori alla medaglia, ho trovato al Cabinet des Dessins i due profili appena abbozzati sui due cartoni pisanelliani, di cui gli scarsissimi studi sull'iconografia di Niccolò III non avevano sinora tenuto conto e di cui parlo nel libro.
Spero che la mia risposta soddisfi la sua curiosità. Naturalmente il processo di ricerca è stato molto più complesso e ha tenuto conto di molti altri dettagli, di cui sarebbe impossibile parlare in una mail. Mi resta peraltro il dubbio dell'orecchio a punta e a questo proposito sono alla ricerca di ulteriore iconografia nonché di eventuali misconosciute o a me sfuggite descrizioni scritte del signore di Ferrara che possano spiegarlo: chissà, le capitasse di leggere qualcosa...
Un cordialissimo saluto,
SR
Fotografia infrarossa della «Flagellazione» (2)
03/03/07
Salve,
la ringrazio molto per la sua risposta alla mia mail riguardante la fotografia infrarossa dell'opera di Piero Della Francesca "La flagellazione di Cristo". Le comunico che sono venuto a conoscenza di un sito in cui è disponibile, previa autorizzazione, la fotografia in oggetto. Il sito è arte.ino.it, come segnalatomi dalla gentile Sig.ra Chiara Mustarelli. Il mio interesse per questo particolare esame è nato in seguito ad una analisi delle ombre proiettate dalle fonti di luce sugli oggetti e sulle persone dipinte da P. della Francesca.
Un esperto che ha contattato l'ente per cui lavoro sostiene che l'area sovrastante la colonna alla quale è legato Cristo, riceve luce dall'esterno, riflessa dal cielo azzurro. I tre intercolumni della loggia, sotto la quale si svolge la flagellazione, sarebbero "tamponati" ossia chiusi, ad eccezione di quello centrale che sarebbe aperto nella parte alta e da questa apertura entrerebbe la luce particolare che illumina la porzione centrale di soffitto a cassettoni.Non sono d'accordo. La luce del cielo che penetra da una finestra non produce a mio avviso le ombre nette che si osservano nel dipinto. Tracciando una linea retta che prolunga i bordi delle ombre si può con una certa approssimazione stabilire la posizione della fonte di luce che produce le ombre stesse. Non è facile spiegarsi a parole, ma la direzione di almeno due ombre mi indica che la fonte di luce è posta fuori dal colonnato, ma vicino ad esso, ad una altezza grosso modo coincidente allo sguardo del Cristo!
Non posso dire che tipo di luce sia, perchè sospetto che ciò che emette luce sia coperto dai tre personaggi posti all'esterno ed in primo piano. Anche la sfera metallica che la divinità sopra la colonna regge con la mano sinistra, presenta i classici riflessi che una fonte di luce "puntiforme", non diffusa, diversa da quella del cielo, produce sulle superfici metalliche. La sfera ha due riflessi: uno, più vicino alle colonne, è netto e forte; l'altro, sul lato opposto, è sicuramente prodotto dal vicino soffitto ed infatti è più ampio e morbido. La fonte di luce che produce il primo riflesso non ha le caratteristiche della luce del cielo.
Un esame fotografico agli infrarossi forse può dare qualche risposta e rivelare il disegno della fonte di luce coperta dal personaggio con barba e cappello in primo piano. A dir la verità non ho molta fiducia negli infrarossi perchè ho fatto alcuni test con delle scritte coperte da semplice bianchetto e una strumentazione che registra fino a 1000 nanometri da me utilizzata non è riuscita a scoprire nulla. Le pellicole fotografiche si fermano a soli 900-920 nanometri. Mi chiedo se un esame radiografico sia possibile e se possa dare qualche possibilità in più.
Spero di non averla annoiata. La saluto con stima.
Claudio
Carissimo Claudio,
ciò che mi scrive è assolutamente affascinante. Purtroppo, non ho le adeguate cognizioni tecniche per darle indicazioni sulla fotografia multispettrale o sulla possibilità di un'eventuale analisi ai raggi X. Tuttavia, se la sua ipotesi è corretta - e neanche su questo saprei pronunciarmi con competenza, ma altri lettori le cui mail sono state inserite in questo Libro degli Ospiti potrebbero dare il loro parere -, non mi sembra sia affatto necessario supporre che Piero abbia realmente disegnato la fonte di luce: anzi, l'effetto sarebbe tanto più emozionante in quanto si tratterebbe di una fonte nascosta, di una sorta di fantasma di luce celato dietro la figura di Bessarione.
Ripeto, non so se la sua ipotesi sia corretta, ma spero proprio che il sito funzioni anche un po' da forum e che qualche lettore più competente di me intervenga a darci la sua opinione.
Per ora, non posso che ringraziarla della passione che la sua ipotesi insieme suscita e manifesta.
SR
Una sottotraccia pagana
23/02/07
Gentile professoressa,
Sono lieto che mi abbia risposto: temevo che quell'ipotesi su Adone fosse davvero troppo strampalata. Confido che lei sarà così cortese da darmi modo di leggere suoi eventuali scritti sul tema della "sottotraccia pagana", come lei dice.
Vede, è un tema che mi intriga assai, forse perchè deploro sia andata smarrita la radice pagana nella nostra cultura. Lo so, il cristianesimo ha dovuto combattere il paganesimo, e per far questo l'ha messo alla berlina (basta vedere ancora oggi la ridicola caricatura di paganesimo che si insegna al liceo); ma considerare incompatibili cristianesimo e paganesimo (e monoteismo e politeismo) è a mio avviso un grave errore teologico, oltre che un impoverimento religioso e culturale. L'uomo ha smesso di essere ecologo quando ha smesso di essere politeista: se vedi Dioniso scorrere nella linfa di una pianta, eviterai di sradicarla, o lo farai coi dovuti riti.
Mi chiede che cosa faccio nella vita. Sono ingegnere, vado in giro a organizzare fabbriche. Poi, a causa di ciò, o anche in vista di ciò, mi occupo di erpetologia, entomologia, botanica, storia dell'arte, musica e teologia. Tutto in modo rigorosamente superficiale, s'intende. Che filo rosso leghi tutte queste curiosità, me lo chiedo anch'io. Forse sono pretesti per sviare il pensiero della morte; ogni tanto, un nuovo pretesto si rende necessario... quale il prossimo?
Suo affezionato lettore
Dario
Caro Dario,
quanto all'errata e "irreligiosa" accezione corrente del paganesimo, e quanto al fondamentale errore teologico che la genera, trova d'accordo non solo me, ma - citando un nome per tutti - James Hillman, i cui scritti suppongo conosca, e con il quale ho pubblicato due dialoghi in cui si parla ampiamente di questi temi. Che andrebbero, certo, ulteriormente diffusi e approfonditi. Lo farà ben presto, e con una risonanza sicuramente ampia, la costituenda "Fondazione Zolla", costituita in memoria e per continuare l'attività di riflessione e di studio di un altro autore che le sarà noto, Elémire Zolla appunto: troverà, al momento opportuno, tutte le notizie in questo sito.
Nel congratularmi con lei per la coerenza e - appunto - religiosità con la quale affronta e la sua professione e la sua vita, mi domando se troverà il tempo di mettere per iscritto la sua ipotesi su Adone, per pubblicarla magari su una rivista alla quale potrei presentarla, e così mantenendole per così dire il copyright o comunque la primazia, in modo che io possa discuterla e svilupparla con i miei allievi o in altre occasioni di dibattito, come ad esempio quella del 15 giugno a Urbino, alla quale chissà se troverà tempo e voglia di partecipare tra il pubblico attivo.
Per ora un augurio di anastasi primaverile,
SR
Fotografia infrarossa della «Flagellazione»
14/02/07
Salve, mi occupo da alcune settimane del dipinto in oggetto. Mi chiedo se esistano fotografie eseguite con pellicole o sensori digitali agli infrarossi del quadro in oggetto. Se ne ha notizia, la prego di comunicarmelo.
Per il tempo che vorrà dedicarmi, anche per una risposta negativa, la ringrazio di cuore.
Con stima sincera,
Claudio
Caro Claudio,
purtroppo non ho notizia di foto della Flagellazione eseguite con sensori digitali agli infrarossi; il che non vuol dire necessariamente che non ne esistano. Ma di qualunque analisi sia stata recentemente effettuate sul dipinto è di certo al corrente Lorenza Mochi Onori, di cui le do qui sotto le coordinate: buona fortuna, e mi faccia sapere!
SR
Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le Marche
* Piazza Rinascimento, 13 - 61029 - Urbino
* Telefono: 0722.2760
* Fax: 0722.4427
* Email: urbino@arti.beniculturali.it
* Soprintendente: dott.ssa Lorenza Mochi Onori
Adonis
13/02/07
Egregia professoressa Ronchey,
ho appena concluso la lettura del Suo Enigma di Piero: l’ho trovato un’opera entusiasmante e commovente. Solo lavori così, di storici intelligenti, sono in grado di prendere noi profani per mano e condurci nelle antique corti delli antiqui homini, a contemplare grandezza e miseria delle umane cose.
Con l’imbarazzo del neofita vorrei proporle una mia riflessione sulla Flagellazione (le mie sono tutte domande mascherate da affermazioni). Da molto tempo prima di leggere il Suo libro ero convinto che i fiori scolpiti sul fondo del cortile giusto intorno al giovane biondo avessero direttamente a che fare con la sua identificazione: la loro posizione non può essere casuale (è strano che Lei non ne faccia menzione). Vede, io sono un ingegnere, ma ho la passione per la botanica, e mi sono fatto l’idea che quei fiori possano essere delle Ranunculaceae, con quelle foglie cauline che sbucano da sotto i petali; in particolare, degli Adonis (molto, molto stilizzati), i fiori che si dice spuntati dal sangue di Adone ferito dal cinghiale.
Bene: se il giovane biondo fosse il dio Adone, il dio della rinascita vegetativa? Certo, è Tommaso, ma potrebbe essere Tommaso in veste di Adone. In fondo l’accostamento non è peregrino: Tommaso, lei mi ha insegnato, “muore” come basileus, ma così come Adone anche Tommaso potrà rinascere attraverso la crociata cristiana.
Se il giovane fosse Adone si spiegherebbe perché la sua figura si staglia contro un albero, l’albero di mirra da cui è stato generato, e perché cinge una cintura vegetale ritorta. Tra l’altro mi risulta che Adone fosse molto amato dai tardo pagani di Grecia, e – chissà – essendo uno dei pochi dei antichi in grado di morire e rinascere, potrebbe avere avuto una qualche importanza nelle riflessioni sincretistiche della Accademia di Mistrà.
A questo punto azzardo una ulteriore interpretazione della Flagellazione, teologica, ferma ovviamente restando l’interpretazione politica che da Lei ho appresa. Il quadro somiglierebbe all’affresco del Buono e cattivo governo di Lorenzetti: a sinistra la cattiva religione, dominata dalle separazioni e destinata inevitabilmente a produrre violenza; a destra la nuova religione, dove ortodossi, cattolici e pagani, simboleggiati dai tre personaggi, “convenerunt in unum”, cioè pervengono ad un culto unificato, ad una visione di Dio unitaria; in attesa che anche i musulmani si aggreghino a loro (ma pretendere un tale quartetto nel XV secolo è pretendere troppo).
Con stima
Dario
Caro Dario,
mail come la sua bastano da sole a ripagare un autore del lavoro settennale di un libro. Né lei mi sembra un profano, anzi, e se tale si considera, allora lo sono anch'io.
La sua riflessione mi coglie purtroppo in un periodo di superlavoro universitario. Mi riservo di meditarla a fondo e di darle un parere più puntuale e articolato non appena gli impegni didattici e le scadenze accademiche mi daranno un po' di respiro.
Per il momento le dico solo che l'idea di una sottotraccia pagana, o paganeggiante nel senso sincretistico in cui il platonismo quattrocentesco lo era, in silenzioso ma non stridente contrappunto con il messaggio più ortodossamente politico-religioso del quadro, non solo è affascinante, ma profondamente consonante con tutto quanto la mia (e non solo mia) ricerca porta in luce: mi appare quindi non solo plausibile, ma, ora che lei la rileva, quasi inevitabile.
Indagherò, ma continui a indagare anche lei, mi raccomando...
A proposito, posso domandarle di cosa si occupa nella vita?
Con stima,
SR
Porta chiusa
05/02/07
ho letto con vivissimo interesse il suo ultimo libro, anche per una ragione di carattere personale: infatti, la tavola urbinate mi diede tempo fa l'ispirazione per un breve racconto,poi utilizzato come soggetto per un cortometraggio (dal titolo indicato in oggetto).
Luca
Caro Luca,
sono molto felice che abbia letto il mio libro, e sarei felice di leggere io il suo racconto, nonché di vedere il cortometraggio che ne è stato tratto. E penso che anche gli altri frequentatori di questo sito lo sarebbero. Ci dà qualche indicazione?
Un cordialissimo saluto,
SR
Nel cuore del libro
05/02/07
Cara Silvia,
forse avrei dovuto aspettare ancora un po' a scriverti ma ho avuto il tuo libro da pochi giorni e già ho bisogno di dirti qualcosa. Innanzitutto, sto avviando la lettura come è mio solito, cioè in maniera random. Purtroppo è il mio sistema di leggere non riesco se non raramente e con grande forzatura a leggere dall'inizio alla fine e ciò anche quando mi trovo davanti a documenti d'archivio o a fonti antiche. Il mio sguardo si muove sulla pagina e sul libro in modo libero. Fortunatamente (correggimi se mi sbaglio) il tuo libro è strutturato per una lettura random. Sono andato avanti nella lettura saltellando tra indice e sollecitazione dei titoli.
Innanzitutto una critica da un viaggiatore testuale random: ho avuto problemi a ritrovare i capitoli nel regesto minore; gli inglesi (e americani) in questi casi hanno la buona usanza di indicare le pagine cui le note a fine testo si riferiscono. Se avessi avuto tale ausilio avrei guadagnato tempo. Cosa costava, ad esempio, a pagina 491, inserire accanto al titolo Vent'anni dopo le pagine 272-274? Oppure, in testa alla pagina 491 scrivere 269-281, che sono le pagine cui le note bibliografiche si riferiscono? Un suggerimento per la prossima edizione specie nel caso tuo nel quale i capitoli sono oltre il centinaio.
Ma tornando a noi, ho ovviamente letto i capitoli una mistica della misura e la prospettiva e la storia. Sul primo ci sono alcune piccole imprecisioni ma che possono colpire solo un pedante come me che insegna e studia la prospettiva e la sua storia. In generale il capitolo tiene dal punto di vista del tuo linguaggio e delle tue finalità, ci sarebbe qualche aggiornamento bibliografico con le alcune cose pertinenti, quali gli scritti di Martin kemp (The Science of Art, 1990), J. V. Field, gli atti sulla prospettiva curati da Marisa Dalai (Piero della Francesca tra arte e scienza, 1996) e un lavoro eseguito da un ricercatore di Pisa sulla restituzione prospettica della Flagellazione attraverso procedure computerizzate. A mio avviso invece sono le "espressioni" di Wittkower (andrò a rivedere il suo lavoro del 1953) di Clark e di altri che non reggono ad una moderna analisi epistemologica, il lor linguaggio è ancora intriso di una visione che definirei "esteticheggiante" che risolve con parole e frasi "liriche" questioni scientifiche a loro ignote o mal interpretate: la frase "la luce proviene da una fonte indefinibile, ma innaturalmente da nord" mi sembra priva di senso; come sono stati individuati i punti cardinali nel dipinto? Così come privo di senso è la ricerca di un modulo cui soggiace l'intera composizione, nel sistema prospettico che nega il modulo. Già Alberti aveva negato il principio della modularità nel digradare del pavimento (I,19). Però per correggere questo linguaggio e i significati che questo linguaggio veicola si è fatto ancora poco; pertanto, non condivido ma tu non avevi altra scelta. D'altronde tutti i lavori che citi sono tra gli anni '50 e, al più, '70 (30- 50 anni fa!).
Ti ho scritto così in anticipo, prima di una lettura più ampia del tuo testo, anche perché vorrei sapere qualcosa da te: cosa conosci tu del rapporto Bessarione-Regiomontano-Piero? Ho letto, ovviamente L'astrolabio di Regiomontano, ma parli di lui solo in quell'occasione. Sono alla ricerca di legami Regiomontano-Piero (che ci devono essere anche se mediati dal Cardinale) e mi chiedo se puoi darmi qualche indicazione.
Un caro saluto e . . . complimenti.
Vladimiro
P.S.: non ti ho detto che la tua ipotesi è convincente e affascinante, così come ho trovato interessanti i riferimenti ai cicli di Benozzo e di Mantegna.
Caro Vladimiro Valerio,
sì, è proprio così, il libro è strutturato anche per una lettura random. Ed è vero quello che scrivi sul regesto minor: è difficile orientarsi, e cercherò di convincere la casa editrice a introdurre le razionalizzazioni che suggerisci nell'edizione paperback, che dovrebbe uscire in primavera. Preziosissime, poi, le tue indicazioni bibliografiche, che pure cercherò di vagliare e di integrare nella nuova edizione del libro.
Quanto ai possibili rapporti tra Piero e Regiomontano, penso che dovresti rivolgerti a David King, lo studioso che ha scritto i saggi relativi all'astrolabio nel catalogo della mostra su Bessarione della Marciana. Fra l'altro, ha di recente proposto una sua interpretazione della Flagellazione legata proprio all'astrolabio, alle sue simbologie e al rapporto tra Regiomontano e l'ambiente platonico italiano cui Bessarione lo introdusse. Ecco il suo indirizzo e-mail: Kingabumax@aol.com. Ed ecco anche il suo indirizzo completo:
Prof. David A. King
Director
Institute for the History of Science
IGN - FB 13
Frankfurt University
D 60054 Frankfurt am Main
Tel. +49-69-7982-2754
- 2337 (Secretary, Herr Wagner)
- 2338 (Librarian, Herr Dyga)
Un saluto cordialissimo, e se hai ulteriori osservazioni, man mano che vai avanti nella lettura del mio libro, mi raccomando, continua a sottopormele!
SR
Altre recensioni
28/11/06
Gentilissima Prof.ssa Ronchey,
in aggiunta alle precedenti, invio la recensione da me pubblicata ne «L'Avvenire dei lavoratori», pervenutami da Zurigo con News letter in data 06 ottobre 2006.
Cordialmente
Giuseppe
L’enigma di Piero
Note a margine di un nuovo saggio di Silvia Ronchey
di Giuseppe Muscardini
La flagellazione conservata alla Galleria Nazionale delle Marche rappresentò davvero un enigma per gli studiosi di Piero della Francesca. Quel soggetto diffusissimo, con Cristo sullo sfondo angariato da due impietosi sgherri, che usano pari violenza a quella vista nel celebre film di Mel Gibson, lo ritroviamo copiosamente nelle chiese e nei musei. Ma nell’opera in questione i critici hanno sempre avuto il dubbio che la flagellazione, posta nel dipinto su un piano prospettico diverso da quello delle tre figure che campeggiano invece nel proscenio sulla destra, valga a depistare l’osservatore in funzione dell’enigmatica rappresentazione di fatti più vicini all’epoca di Piero, che non a quella di Cristo.
È seducente l’ipotesi di Silvia Ronchey, autrice di questo libro dall’impianto singolare: attraverso opportuni riferimenti mutuati della più recente indagine storiografica, e comparando con l’iconografia conosciuta le fisionomie e gli abbigliamenti dei personaggi raffigurati in seria conversazione fra di loro, si può dedurre che i tre non sono altri che Bessarione, Niccolò III d’Este (promotori nel 1438 del celebre Concilio di Ferrara) e il "porfirogenito" Tommaso Paleologo, interessato al potere dinastico dell’impero bizantino. Quel concilio, cui partecipò Giovanni VIII Paleologo - per l’occasione ospitato a Palazzo Paradiso - fu indetto per unificare le chiese di Oriente e di Occidente in disaccordo su questioni teologali, ma in un momento in cui incombeva il pericolo della fine dell’Impero di Bisanzio, minacciato dall’Islam. Iniziato a Ferrara, ma conclusosi a Firenze poiché un’epidemia di peste colpì la popolazione ferrarese, negli annali della Chiesa il concilio fu considerato evento straordinario, paragonabile nella nostra storia più recente alla conferenza di Yalta. Un evento che tuttavia non servì ad impedire quindici anni dopo la caduta di Costantinopoli, conquistata dai Turchi nel 1453.

In considerazione del fatto che il controverso dipinto di Piero della Francesca è datato al 1455, Silvia Ronchey attinge sapientemente all’iconografia ufficiale e confronta le sembianze del Paleologo (cappello importante dalla visiera pronunciata) con l’effigie su monete e medaglie, oltre che con l’immagine del codice noto come La Spagna in rima, conservato presso la Biblioteca Ariostea. Raffigurato di profilo anche da Piero, con occhio venato dal dubbio il Paleologo assiste alla flagellazione di Cristo in luogo di Pilato, mentre un uomo di spalle con turbante e caffettano, impersonando il sultano turco, muove verso il colonnato dove si svolge la scena per godere da vicino del supplizio da lui stesso ordinato.
Ecco dunque Ferrara, di cui si intravedono in uno scorcio sulla destra - secondo l’interpretazione all’autrice - le solenni architetture; ecco Ferrara, luogo della possibile concordia fra credenze e fedi diverse; ed ecco Niccolò III d’Este, con il capo rasato e il sottomento adiposo, il regnante che mandò a morte il figlio Ugo e la giovane moglie Parisina colti in flagrante adulterio, ma capace di far confluire nella città estense le personalità religiose più in vista del suo tempo, per pacificare gli animi di credenti e politici.
L’ipotesi di Silvia Ronchey si fa ancora più interessante quando si riscontra, avanzando nella stimolante lettura, come l’argomento sia ben suffragato da ricerche serie e approfondite. Se veritiera, l’interpretazione della studiosa aggiungerebbe un tassello significativo all’iconografia estense, con Niccolò III raffigurato dal grande Piero della Francesca; ma, ancora più importante, comproverebbe uno storico precedente di cui possiamo andare fieri ancora oggi: Ferrara città della pace, anche all’epoca di Piero. A una settimana dalla morte di Oriana Fallaci e dall’inizio delle infuocate polemiche che hanno seguito il discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, nel tentativo di sciogliere un enigma questo libro lascia comunque ben sperare nella possibilità di un dialogo. Così come avvenne un tempo, proprio a Ferrara.
SILVIA RONCHEY, L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006
Niccolò Pizzolo
19/11/06
Ho scoperto che il mio Sant'Agostino è in realtà un Sant'Ambrogio e che il mio Niccolò Pizzolo è Nicolò Pizolo; ciò che rimane sono comunque i frammenti delle foto; non so se Amicare Pizzi nel 1944, nella sua campagna fotografica per il libro di Fiocco sugli Eremitani (del 1947 che non son riuscito a trovare) ha realizzato immagini a colori delle lunette.
A proposito di Bessarione, non furono le argomentazioni contenute nel De Spiritu Sancto di Ambrogio (primo a parlare di filioque), insieme con gli scritti di S. Ilario, Sant'Agostino e Leone Magno, a "convincerlo?" alle tesi della chiesa romana?
Per le immagini degli Eremitani il sito è
http://www.progettomantegna.it/gal.html
Cordiali saluti
Sergio
Altre recensioni
17/11/06
Gentilissima Prof.ssa Ronchey,
negli ultimi mesi ho avuto occasione di pubblicare recensioni a L'enigma di Piero in periodici italiani ed elvetici. Su consiglio del comune amico Marco Bertozzi, Le invio le stringhe dei periodici on-line in cui la recensione compare:
1. L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006, recensione al romanzo di Silvia Ronchey, in Leggoanch’io, rubrica di recensioni in in Eventi culturali de «Il Bernina», periodico on-line di Poschiavo (Svizzera), martedì, 24 ottobre 2006; http://www.ilbernina.ch/evento.php3?inserto=5&pagina=4
2. L’enigma di Piero. Note a margine di un nuovo saggio di Silvia Ronchey, in «L’Avvenire dei lavoratori», periodico cartaceo e on-line di Zurigo (Svizzera), Rubrica “Il libro”, venerdì 6 ottobre 2006; News letter ADL 06/40.5 del 6 ottobre 2006; cfr. inoltre Servizi del giorno.
3. Recensione al libro di Silvia Ronchey, L’enigma di Piero, Milano, Rizzoli, 2006, in Volta la carta, rubrica di segnalazioni bibliografiche del periodico on-line «Cronaca Comune» di Ferrara, lunedì 25 settembre 2006; http://www.cronacacomune.fe.it/index.phtml?id=994.
So che i Suoi impegni culturali La porteranno a breve a Ferrara. In attesa di stringerLe la mano e di congratularmi personalmente per il meritato riscontro ottenuto con L'enigma di Piero, Le auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti.
Giuseppe
Ritratti di Bessarione (2)
15/11/06
Non so se la mia è una ossessione, ma anche in questa immagine di Del Chierico mi pare sia in primo piano.
Non sono riuscito a verificare chi partecipò alla dedicazione di Santa Maria del Fiore (1471- 25 marzo?), è possibile la presenza di Bessarione? Le riesce di verificarlo?
Saluti
Sergio

Non so se nel 1471 per l'innalzamento della sfera del Verrocchio sia stata rinnovata la cerimonia celebrata nel corale.
Non ho trovato notizie di solennità a Firenze nel '71 che potrebbero giustificare Bessarione nei panni di Giordano Orsini .Il naso mi pareva niceno.
Il 25 marzo 1436, 138 anni dopo la posa della prima pietra, la cattedrale veniva consacrata dal papa Eugenio IL, che a quel tempo si trovava a Firenze. "Il giorno venticinque di marzo, ch'è la festa dell'Annunciazione ed era, in Firenze, principio dell'anno, il papa Eugenio AL consacrò il tempio di S. Maria del Fiore... Fu celebrata quella consacrazione con molta grandissima solennità, essendosi dalle scalee di Santa Maria Novella, dove il Papa dimorava, insino a quelle del Duomo alzato un palco alto da terra circa tre braccia, ricco di tappeti e d'ogni magnificenza, sul quale andassero fuori della calca egli e tutto lo accompagnamento suo, ch'erano molti Cardinali e Vescovi e Principi e Ambasciatori, e tutta la Signoria, tenendo la coda del papale ammanto il gonfaloniere Davanzati, che fu da Eugenio, per mano di Sigismondo Malatesta, fatto insignire della cavalleria" (G. Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, II, 1). Il Pontefice consacrò di sua mano l'altar maggiore, mentre il cardinale Giordano Orsini consacrava il resto del tempio. Pochi giorni innanzi, Eugenio IV aveva donato alla Chiesa Metropolitana la Rosa d'oro.
Terminata la cupola, fu messo mano alla lanterna, anch'essa opera del Brunelleschi, il cui primo marmo fu posto il 25 marzo 1445, alla presenza dell'arcivescovo Antonino Pierozzi, che aveva preso possesso della diocesi il precedente 13 marzo. Morto il Brunelleschi il 16 aprile 1446, l'opera della lanterna fu continuata da altri e fu del tutto terminata il 23 aprile dell'anno 1461.
Nel 1471 fu collocata la grande palla di bronzo dorato, che era stata commessa ad Andrea del Verrocchio, ed infine la croce che sovrasta alla palla, anch'essa di bronzo dorato.
.Estratto da:
Ufficio Diocesano di Documentazione e di Ricerca, "La Chiesa Fiorentina", Libreria Editrice Fiorentina 1993 (a Cura di Giulio Villani e Vittorio Cirri)
Ho trovato invece un'altra immagine che ritengo molto importante. E' il Sant'Agostino che Niccolò Pizzolo dipinse prima del 1453 (anno della morte) nella chiesa degli eremitani di Sant'Agostino in Padova, purtroppo perduto nei bombardamenti del 1944.
Ho reperito una discreta riproduzione dell'affresco che allego. E' una pregevolissima prospettiva che ha sicuramente ispirato la maniera un po' scultorea dei dipinti di Mantegna (che gli era accanto). Credo possa costituire un passaggio credibile fra il Bessarione di Piero e il Sant'Agostino del Carpaccio. Il naso è un po' "duro", scultoreo, come nel mio stendardo, ma credo dipenda da chi dipinge.
Mi pare che l'immagine sia eccezionale; gliela dovevo dopo la mezza "bufala" di stamattina
Ancora cordiali saluti
Sergio
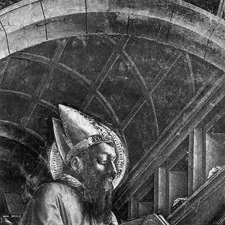
Carissimo Sergio,
la Dedicazione Santa Maria del Fiore di Antonio Del Chierico non la ritengo una bufala, tutt'altro. Anche se commemora un evento del 1436, lo fa nel 1471, e dunque è anche possibile che i tratti di Bessarione siano stati prestati dall'autore a uno dei cardinali. Il problema - e il motivo per cui non le avevo risposto subito - è che nella riproduzione che mi ha inviato, in Word, non riesco a distinguere né i tratti dei volti (non capisco neppure se qualcuno ha la barba!) né i colori degli abiti cardinalizi, mentre questo, come ben sa, specie nel '71, è un dettaglio importante. Se uno dei cardinali ha la barba e indossa un abito nero, un riferimento a Bessarione c'è. Pensa di riuscire a inviarmi un'immagine più leggibile?
Quanto al Sant'Agostino di Niccolò Pizzolo, è indubbiamente notevolissimo (barba più tiara cardinalizia!), ma anche qui la foto è in B/N e non si distingue il colore dell'abito, che invece sarebbe importante. Non so se lo si possa considerare un anello di congiunzione tra Piero e Carpaccio in senso stretto (la mia congettura è che Piero avesse per modello un cartone realizzato a Ferrara, raffigurante Bessarione trentenne in panni bizantini), ma senz'altro il ritratto (o la sua fonte iconografica) è un precedente di quello di Carpaccio. La sua data di composizione (ante 1453) ben si attaglia all'età che Bessarione aveva all'epoca (45 anni) e dunque a una barba ancora scura: appunto come quella che ha in Carpaccio. E ha ragione a dire che la forma del naso è una via di mezzo tra quello di Berruguete e quello del telero di San Giorgio: diciamo un punto di partenza credibile per l'evoluzione cui assistiamo in quest'ultimo, e che è l'unico vero elemento di dissonanza fra il ritratto di Carpaccio (che sicuramente raffigura Bessarione) e la lignée di nasi niceni, ormai bene attestata anche grazie ai suoi apporti, che lega il Bessarione di Piero a quello di Berruguete e alla miniatura di Gioacchino de Gigantibus.
In conclusione, come sempre il suo occhio è acutissimo: ma, di nuovo, pensa di poter procurarsi una riproduzione a colori di Pizzolo, o almeno un'indicazione sul colore dell'abito?
Oltre alla tavola rotonda di Urbino (che a quanto pare si svolgerà tra giganti: sono stati invitati dalla D.ssa Mochi Onori niente meno che Settis, Ginzburg, Paolucci, Bertelli, Strinati, Treffers e Marilyn Lavin), stiamo organizzando un precedente convegno, più strettamente iconografico, che dovrebbe svolgersi a Firenze all'inizio della primavera. Sarebbe magnifico se lei volesse presentare in quest'occasione ufficiale i suoi ritrovamenti!
Per ora un cordialissimo saluto e un grazie sentito,
sua
SR
Ritratti di Bessarione
03/11/06
Ritengo che l'immagine del san Girolamo di Marco Costanzo sia davvero importante perchè più che l'anello
di congiunzione tra il Bessarione di Berruguete e il Sant'Agostino di Carpaccio, credo sia il trait d'union fra
il Bizantino di Piero e il Bessarione di Berruguete; direi anzi trattarsi proprio di tre ritratti della stessa persona
fatti dal vero e non da descrizione, che il tratto saliente sia proprio l'occhio sporgente (un po' alla Lionel Stander,
quello di Per grazia ricevuta), appena più evidente nell'immagine siciliana, oltre allo stesso naso, lo stesso ovale, le
stesse labbra, la stessa barba, in età diverse. Sono tratti che si raccontano, ma che se non si vedono non si rappresentano.
In Costanzo e in Piero il profilo è quasi lo stesso.
Le invio la scheda su Marco Costanzo che si può facilmente trovare nel Quattrocento dell'Electa (dove unica
immagine è, in bianco e nero, la Trinità del Museo Bellomo).
Circa i legami con Bessarione del San Girolamo di Siracusa, credo che passino per Urbino; è proprio qui che
venne fondato, dal Beato Pietro Gambacorta da Pisa l' "Ordo fratrum eremitarum s. Hieronymi congregationis
b. Petri de Pisis", e sino al 1860 ha avuto sede la "casa madre", in un sito donato all'ordine da Ottaviano degli Ubaldini;
Martino V e poi Eugenio IV, approvarono e arricchirono di privilegi la nuova congregazione che si diffuse
in tutta Italia (sant'Onorio al Gianicolo, San Sebastiano a Venezia solo per dire alcuni dei conventi) . E' sopravvissuta
fino al 1933. A presto
Sergio

L'enigma e il cinema
31/10/06
Illustre Professoressa,
mi permetto di disturbarla per inserirmi nell’elenco di coloro che si sono complimentati con lei per la splendida ricerca sulla Flagellazione di Piero della Francesca edita recentemente da Rizzoli.
Sono un quarantacinquenne lettore di Roma, funzionario del Ministero dell’Interno, abilitato all’esercizio dell’attività di guida turistica con interessi da profano per la storia dell’arte.
Quel che mi ha colpito nella sua ricerca, oltre all’affascinante approccio interdisciplinare generalmente raro nelle opere degli addetti alla materia, è stata soprattutto la capacità del tutto originale di attrarre il lettore nel mondo della storia dell’arte con lo stile di un consumato romanziere o di un esperto regista cimematografico senza arrecare il minimo danno alla serietà e alla scientificità del lavoro.
Colgo l’occasione per segnalarle un mio piccolo dubbio: alla pag. 8 Andrea apostolo viene definito come leggendario fratello di Pietro. Mi lascia perplesso una tale definizione riferita ad uno dei dodici apostoli che, come tralaltro lei stessa ricorda nel testo, è citato più volte nei Vangeli, e la cui storicità non è più dubbia dei restanti undici. (cfr. Mt 4,19; Mc 1,16; Lc 6,12; Gv 1,40).
Mi permetto infine di segnalarle un piccolo refuso: a pag. 112 la raffigurazione del personaggio in coda alla corte di Gaspare che rappresenta lo stesso Benozzo Gozzoli è indicato erroneamente alla tav. 126, mentre in realtà è alla num. 26.
Nella speranza di avere l'onore di poterla conoscere personalmente, mi complimento nuovamente e la saluto cordialmente.
Giuseppe
Roma, 31.10.2006
Carissimo Giuseppe,
l'allusione cinematografica mi manda in visibilio: non ci crederà, ma questo libro, rigurgitante di materiale scientifico, l'ho scritto fingendo sempre di avere davanti una macchina da presa. E la ringrazio delle due segnalazioni. In effetti non è certo "leggendario" in sé Andrea, ma solo, secondo alcuni biblisti, che fosse fratello di Pietro in senso carnale. Correggerò l'equivoco nella prossima edizione. Nel frattempo, nella terza edizione è stato corretto anche il refuso di p. 112.
Spero anch'io di incontrare un così attento lettore: magari in una delle manifestazioni su Piero che nel corso dell'anno si svolgeranno in varie città, e spero anche a Roma, prendendo spunto proprio dal mio libro.
Un grato e cordiale saluto,
SR
Un'immagine di Bessarione? (3)
28/10/06
Mi scuso per l'involontaria omissione, provvedo all'invio.
Si tratta per me di una scoperta recente e sono ancora alla ricerca di notizie.
le invio anche la e-mail che ho inoltrato, senza esito, al responsabile dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiali e Arte Sacra di Sircusa. L'immagine per quanto
ho letto, proviene dalla chiesa di San Gerolamo fuori le mura.
Comunque se riuscirò in questi giorni a costruire una breve comunicazione sensata e coerente mi piacerebbe partecipare al convegno di presentazione del suo libro.
La ringrazio per l'attenzione e le porgo i miei più cordiali saluti.
Sergio
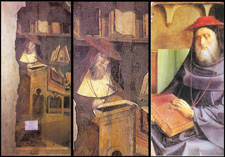
Un'immagine di Bessarione? (2)
18/10/06
Esiste un'altra immagine, in Sicilia, una tavola datata 1468, che rappresenta Bessarione (ne sono certo) nelle vesti di San Girolamo nello studio, un tre-quarti del lato opposto del viso, inequivocabilmente un ritratto (e fa considerare tale anche quello dello studiolo di Urbino), in tutto e per tutto simile a quello del Louvre. Stessa barba (un po' più scura), stesso modo di portare il cappello, stesso naso e anche qui occhio semichiuso e occhio aperto.
Glielo invio affiancato a quello di Berruguete per il raffronto. saluti
Sergio
Carissimo Sergio,
perdoni il ritardo con cui le rispondo ma tra la schiena fratturata che mi sfinisce già di suo e una fastidiosa influenza che non voleva più finire sono rimasta indietro con tutti i miei impegni e più ancora con la corrispondenza.
Sono interessatissima dalla tavola siciliana di cui mi parla, anche se non ho ricevuto alcuna immagine in attachment alla mail... Il che non fa che aumentare la mia curiosità.
I suoi apporti all'iconografia bessarionea si stanno moltiplicando e anche per questo mi domando, e le domando, se lei non voglia partecipare al miniconvegno di presentazione del mio libro che si sta organizzando tra Urbino, Pesaro e Rimini: l'idea è venuta alla D.ssa Mochi Onori quando ci siamo viste a Frontino, e subito hanno aderito sia il rettore di Urbino Bogliolo, sia l'Assessore alla Cultura di Rimini, sia Marcello Di Bella. E' probabile che la sede sia proprio la sua città.
Per ora non ho ricevuto comunicazioni sulla data e sull'organizzazione, ma tenevo a informarla subito, perché sarebbe bello se lei volesse presentare in tal modo i suoi ritrovamenti iconografici in sede scientifica, così che io mi senta libera di utilizzarlo poi in sede didattica e di indicarli ai miei allievi per le loro ricerche senza sottrarle, per così dire, il copyright...
Aspetto dunque l'immagine che mi annuncia e la saluto davvero cordialmente,
sua
Silvia Ronchey
Articolo Maurizio Calvesi
26/09/06
Cara Professoressa,
dopo che ho ricevuto il Vostro e-mail subito sono andato comprare il volume dell'Art e Dossier. Sicuramente ho sbagliato io, ma il numero 75 del 1993 é un volume dedicato a Cezanne.
Carissimo Mons. Nemeth,
il rimando bibliografico all'articolo di Calvesi che le ho inviato, e che è presente nell'apparato del libro, mi risulta corretto. Purtroppo non l'ho in casa, altrimenti gliene invierei una fotocopia, ma il catalogo-spoglio del Kunsthistorisches Institut Florenz dà come collocazione "Art e dossier, 8.1993 No. 75, p. 38-42", ed una ricerca su internet fornisce sempre i medesimi dati. Forse lei ha acquistato il dossier n. 75 (si trovano comunemente in tutte le librerie), ma in realtà qui si fa riferimento alla rivista (che invece andrebbe richiesta come arretrato).
Con i più cordiali saluti,
SR
La battaglia del 1456
20/09/06
Con piacere ho letto il Vostro libro l'Enigma di Pero. Alla pagina 245 Lei srive: secondo alcuni miei colleghi, alla loro sconfitta del 1465 sul Danubio. Si potrebbe sapere o leggere di questo di piz. Chi sono questi colleghi? Dove ne hanno scritto? ecc.
Gradirei una risposta in merito.
Mons. Laszls Nimeth
Caro Mons. Nimeth,
gli studiosi che si sono spinti a scorgere nella Battaglia di Costantino e Massenzio una precisa memoria della vittoria contro i turchi conseguita nel 1456 (non 1465) sono Maurizio Calvesi e Franz Büttner. Ecco i riferimenti:
M. Calvesi, La Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. I due Giovanni all’ultima crociata, “Art e Dossier” 75 (1993), pp. 38-41;
F. Büttner, Das Thema der Konstantinschlacht in Piero della Francesca, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz” 1-2 (1992), pp. 23-40.
I rimandi a queste opere, come a tutte le altre fonti primarie o secondarie che vengono direttamente o indirettamente menzionate nel mio libro, che sono onorata e lietissima abbia attratto la sua attenzione, compaiono nel Regesto Maior pubblicato online per ragioni di spazio e reperibile integralmente sia all'indirizzo indicato a p. 446 del volume (http://www.rizzoli.rcslibri.it/enigmadipiero) o all'interno del mio sito (www.silviaronchey.it), insieme alle relative abbreviazioni bibliografiche.
Con un cordialissimo saluto,
SR
Altre ipotesi sulla «Flagellazione»
14/09/06
Gentile professoressa,
ho letto con passione il suo libro "L'enigma di Piero" e vorrei in primo luogo ringraziarla per averlo scritto.
Per progettare un opera divulgativa di oltre 400 pagine, con un corredo di apparati gigantesco, bisogna essere parecchio coraggiosi. Se poi l'opera in questione riguarda uno specifico periodo della storia bizantina, riflesso nell'immagine di un quadro, bisogna essere persino un po' folli. Nel suo caso il coraggio e la follia sono benedetti dal talento e i risultati sono sorprendenti.
Il suo stile narrativo, avvincente e frammentario, risulta estremamente godibile anche per il lettore più profano, che la segue nella sua ricerca come il topino segue il pifferaio magico. La ricchezza delle citazioni e dei riscontri presentati nel libro, lungi dallo stancare, lusingano il lettore che si sente messo a parte, nello spazio di pochi giorni, di una conoscenza sterminata, acquisita da generazioni di dottissimi studiosi.
Il rischio conseguente è che il lettore profano, specie quello profondamente ignorante come la sottoscritta, si senta, dopo aver letto il suo libro, un piccolo esperto di storia bizantina (nel deserto dell'ignoranza l'unico fiore che cresce facilmente è quello della presunzione) e voglia cimentarsi con variazioni sul tema delle interpretazioni della Flagellazione, così riccamente presentate nel suo libro.
Il senso del ridicolo e la consapevolezza di importunarla con azzardi interpretativi, per i quali non posseggo alcuna competenza, non bastano a distogliermi dalla tentazione di sottoporle le mie elucubrazioni, delle quali lei stessa è parzialmente corresponsabile, per avere acceso in me, come in moltissimi altri suoi lettori, un interesse tanto forte.
Allego quindi un breve appunto in cui le sottopongo due ipotesi:
- che l'intento del quadro sia, non tanto quello di celebrare il concilio di Ferrara, quanto quello di denunciarne il fallimento, attribuendone la colpa a tre delle parti intervenute;
- che il diverso orientamento della fonte di luce possa essere interpretato come una rappresentazione primordiale del fuso orario, volta a sottolineare la lontananza nello spazio delle due scene rappresentate e la loro contemporaneità.
Concludo pregandola di perdonare la grossolanità degli strafalcioni in cui si imbatterà leggendo l'appunto allegato e ringraziandola in ogni caso per il tempo dedicatomi.
Confesso di invidiare i suoi studenti.
Emilia
Cara Emilia,
ho appena aperto la posta e le dico subito - anzi, subito dopo averla ringraziata di quanto mi scrive - che le due ipotesi che avanza, e su cui mi riservo di leggere con un po' di calma il suo appunto, sono ottime. Quella del fuso orario assolutamente seducente. Quella della denuncia a mio avviso un po' da sfumare, ma parzialmente confermata e comunque implicata in ciò che scrivo riguardo alla possibile committenza all'interno del Regesto Maior (quello che si legge solo online, non so se l'ha visto).
Ma le risponderò meglio appena avrò letto la sua argomentazione. Tenevo però intanto a riscontrare subito la sua meravigliosa mail. A presto,
Silvia Ronchey
Complimenti
28/08/06
Gentile Prof.ssa Ronchey,
Le scrivo per complimentarmi vivamente con Lei per il suo avvincente ultimo libro sulla Flagellazione. Amante della pittura del divin Piero, seppur solo profano di studi critici, glosse e regesto, ho gustato con enorme piacere l'affresco da Lei tracciato di quel complesso periodo storico e delle sue implicanze sulla creazione dell'opera.
Consapevole della difficoltà di rendere accessibili anche ai non esperti le sottili armi della critica artistica, Lei è riuscita a superare brillantemente anche questo scoglio, instillando curiosità e passione nell'approfondire la conoscenza dell'opera, del pittore e della cultura da lui così magnificamente rappresentata.
Ancora grazie,
Ugo
Un'immagine di Bessarione?
20/07/06
E' un particolare dello stendardo della Confraternita di San Giovanni Battista (quella degli affreschi dei Salimbeni) presentato lo scorso anno in occasione della mostra sul Rinascimento Urbinate (Fra Carnevale).
Ritengo sia databile 1472 per la venuta ad Urbino del Bessarione di fine aprile, in occasione della Cresima di Guidubaldo.
Credo di doverglielo perchè qui Bessarione (l'immagine è speculare di quella nota aragonese) in abito da cerimonia (non il nero saio da monaco basiliano) è senza libro insieme con Zoe Paleologina (il cappello frigio è una insegna regale come l'abito rosso), che io non conoscevo. L'immagine è "scannerizzata" dal catalogo Electa.
Come ha capito le identificazioni sono solo mie; le sarei grato se mi facesse sapere qualcosa in merito.
Cordialità
Sergio

Caro Sergio,
la sua indicazione è non solo preziosa, straordinaria. Bessarione è senz'altro lui, e anche l'identificazione con Zoe Paleologina della giovane vestita di porpora e berretto frigio ha ottime probabilità di essere esatta. Purtroppo sono immobilizzata a letto con una vertebra rotta (sono rovinosamente caduta a Siena, per le scale dell'università, mentre trasportavo libri bizantini serviti ai miei studenti per gli esami) e non posso precipitarmi, come vorrei, in biblioteca. Ma ora inoltro la sua mail e la sua immagine a una mia specializzanda che sta facendo il suo tirocinio estivo al Kunsthistorisches Institut di Firenze e la incarico di fotocopiarmi TUTTO del catalogo Skirà, e quant'altro possa essere utile. Nel frattempo cercherò di riflettere che cosa ci faccia l'ineffabile coppia di bizantini sullo stendardo della Confraternita di San Giovanni Battista (santo, peraltro, protettore a Bisanzio della dinastia dei Paleologhi, nonché associato a Bessarione anche in taluni testi - Bessarione, il prodromos - oltreché, secondo una mia fantasia assolutamente non provabile e forse neppure probabile, da Piero stesso nel Battesimo di Londra... Ma ripeto, resto in attesa di più precise notizie sulla datazione, occasione, ambientazione del dipinto per formulare qualsiasi ipotesi. Intanto la ringrazio davvero moltissimo dell'indicazione e spero davvero che rimarremo in contatto.
Un saluto invertebrato,
Silvia R.
Il catalogo della mostra è di Skirà. Avevo inviato la stessa foto ed il testo allegato in ottobre a Concetta Bianca;
non ne ho saputo niente "Ritengo di far cosa gradita inviandole una immagine di colui che ritengo Bessarione, in abito sontuoso (alla sinistra di Federico da Montefeltro e Ottaviano?, alla destra di Battista Sforza?) forse in occasione del suo ultimo soggiorno urbinate (aprile-maggio '72), che sembra speculare di quella contenuta nel codice aragonese "In calumniatorem Platonis". E' un particolare di uno stendardo (rivelatosi inaspettatamente di pregevolissima fattura - potrebbe trattarsi del primo Signorelli) della Compagnia di San Giovanni Battista, restaurato di recente ed ancora in mostra in Palazzo Ducale a Urbino in occasione della piccola mostra allestita su "Fra Carnevale". E' pubblicato nel catalogo, ma a Bessarione non si fa cenno. Cordiali saluti"
Sergio
Complimenti
02/06/06
Gentile professoressa,
ho acquistato per caso il suo testo. Sono rimasto stupefatto. Ho scoperto
Bisanzio per caso con Norwich e poi con Meschini.
Mi ha sempre sorpreso la rimozione di una parte così importante della nostra
storia.
Poi è arrivato il suo testo è so è dischiuso un universo totalmente
sconosciuto, in quanto poco praticato dagli studiosi.
Grazie non solo per la competenza e la passione, ma per aver scritto un
libro che si legge come un romanzo.
Sarà il punto di partenza per altri approfondimenti.
Francesco
Domanda di una studentessa
27/05/06
Salve,
sono una studentessa di beni culturali dell'università di Salerno.Ho letto un articolo su un settimanale dove parlando di enigmi bizantini si è affrontato l'argomento dell'enigma della "Flagellazione" di Piero della Francesca con una Sua interessante intervista.Potrebbe se possibile darmi ulteriori informazioni in merito all'argomento?Lei ha offerto un' interpretazione molto interessante,quali sono le fonti grazie alle quali è riuscita a risolvere l'enigma della "Flagellazione"?Quali sono le documentazioni grazie alle quali è riuscita con assoluta certezza a svelarne il mistero?
Mi chiedo quale impatto questo Suo studio possa avere sulla storia dell'arte e mi chiedo inoltre come mai nessun altro prima di Lei è riuscito a spiegarsi il significato iconologico dell'opera pur essendo assolutamente esperto in materia.
Le porgo i miei complimenti per tutti i lavori e le ricerche che ha svolto in merito.
Cordiali saluti.
Elena
Gentile Elena,
ho impiegato sette anni a rispondere alle domande che mi propone! L'ho fatto scrivendo un libro, "L'enigma di Piero", che è appena uscito da Rizzoli e che era infatti lo spunto della mia intervista. In questo libro troverà tutte le informazioni in merito, l'intera documentazione (in parte fornita a stampa nell'appendice, in parte, data la mole dei riferimenti, fornita online all'indirizzo web che troverà indicato nel libro), e tutta la storia degli studi, delle teorie, degli equivoci e delle intuizioni seguendo le quali ho ricostruito quello che non solo io ma colleghi insigni quali ad esempio Salvatore Settis crediamo sia il significato della Flagellazione.
Mi farà piacere se, dopo aver letto il libro, sempre che ne abbia voglia, vorrà farmi conoscere i suoi commenti.
Grazie del suo interesse,
Silvia Ronchey

